PRESENTAZIONE > Decadenza, declino. Non è un tema nuovo,…
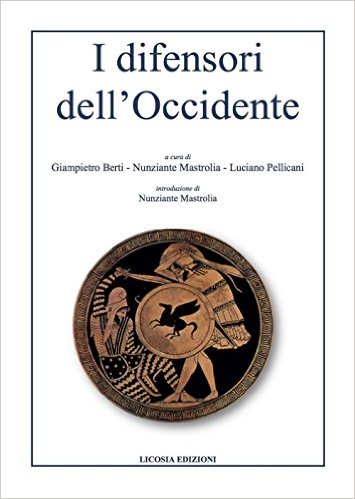
I difensori dell’Occidente 1. Introduzione di Nunziante Mastrolia
di Nunziante Mastrolia >
Questo volume raccoglie gli scritti di alcuni tra i maggiori studiosi italiani, dedicati ad una serie di intellettuali, che spesero la propria esistenza e dedicarono la loro opera in difesa dell’Occidente, negli anni in cui lo scontro tra opposte visioni del mondo, con una stessa ambizione globale, era più intenso. Sono i difensori dell’Occidente.
E’ indubbio che la parola “Occidente” abbia una straordinaria forza evocativa. Dentro quella parola c’è Ulisse, si sente lo stridere delle sartie, lo scricchiolio dei legni, l’ansia dell’orizzonte e l’irrequietezza del domani. C’è l’epica resistenza dei comuni italiani contro il Barbarossa e ci sono i padri fondatori americani, che fecero l’America pensando alla Roma repubblicana. C’è l’Ottantanove di Parigi e quello di Berlino, quando dei ragazzi disarmati presero a picconate quel muro; c’è Maratona e i soldati americani euforici in una Roma liberata in festa. In quella parola c’è Pericle e Churchill, Socrate e Popper.
Insomma, la forza evocativa e la capacità suggestiva di quel termine è enorme. Tuttavia, richiede una qualche precisazione. In primo luogo, perché, sebbene chiaramente utilizzata in chiave idealtipica, con quella parola si escludono fenomeni ed esperienze che pur dovrebbero farne parte, basti pensare al caso del Giappone, di Taiwan, della Corea del Sud o finanche della Turchia di Mustafà Kemal, paesi cioè che hanno abbracciato in toto il modello occidentale. Nel contempo, in quel termine vi si includono altri fenomeni ed esperienze che non dovrebbero farne parte, dagli autodafé all’olocausto, dalla tratta degli schiavi agli stermini di popolo.
Per la presentazione del libro vai qui
Per dirla diversamente, l’Occidente nella sua storia ha tutto e il contrario di tutto, dalla caccia alle streghe al movimento per i diritti degli animali, dall’Inquisizione alle suffragette, ed è proprio questo che rende difficile, se non impossibile, la creazione di un vero idealtipo condiviso globalmente.
C’è un’altra ragione per la quale il termine “Occidente” ha bisogno di una precisazione e cioè il fatto che esso indebitamente crea una cesura, una separazione tra un “Noi”, the Capitol on the Hill, ed il resto del mondo che brancola nelle tenebre. Con il che si corre il rischio di attivare assurde reazioni identitarie da parte di quanti sentono le libertà occidentali, che pure potrebbero desiderare, come il prodotto di una cultura altra: è il caso di quanti respingono le libertà occidentali in nome, per fare un esempio, dei “valori asiatici”, dietro i quali facilmente si intravedono i connotati del dispotismo. Ed è qui l’assurdo: si rifiutano quelle libertà, che pur possono aprire la strada ad una vita più confortevole e libera, in nome di un dispotismo odioso, che però appare più accettabile in quanto percepito come il prodotto della propria tradizione.
Inoltre, creando questa separazione, si rischia di trasmettere un messaggio sbagliato, l’idea cioè che quanto di meglio l’Occidente ha creato (dalle libertà liberali alla ricerca scientifica) sia in qualche modo legato in maniera quasi indissolubile alla particolare storia che questo pezzo di Eurasia ha vissuto. E’ certamente vero che le democrazie liberali sono il prodotto di un particolare percorso storico. Tuttavia quel percorso è replicabile ovunque, quasi come un ragionamento logico. Il che significa che sia quei principi che quelle istituzioni, che hanno visto la luce in Europa, possono attecchire sotto i cieli più diversi. Se così non fosse, si cadrebbe in una qualche forma di determinismo che rischierebbe di scivolare velocemente verso una qualche forma di razzismo.
E’ per questa serie di ragioni che è necessario precisare che con il termine “Occidente” si intende esclusivamente la “società aperta” di Popper. Una categoria che ha il vantaggio: di includere esperienze geograficamente e culturalmente diverse; di essere più semplice da adoperare nel separare, anche all’interno della storia occidentale ed europea, ciò che è proprio di una “società aperta” e ciò che, al contrario, appartiene al suo opposto, vale a dire alla “società chiusa”; ed infine di essere più agevole nell’indicare che la via che conduce alla “società aperta” è una strada percorribile da ogni società, a prescindere dal proprio passato, il che significa che né la storia né la tradizione possono imprigionare in eterno i popoli che aspirano alla libertà ed al benessere. In sintesi, per “Occidente” deve intendersi la “società aperta”, vale a dire un insieme correlato di istituzioni accessibili a chiunque e trapiantabili ovunque.
I difensori dell’Occidente, curato da Giampietro Berti, Nunziante Mastrolia e Luciano Pellicani, è il primo volume della collana “Sociologia & Filosofia”, diretta da Berti e Pellicani. Il volume raccoglie gli scritti, di alcuni tra i maggiori studiosi italiani, dedicati a quegli intellettuali che, negli anni in cui più duro era lo scontro ideologico nel corso della Guerra Fredda, si schierarono in difesa delle “società aperte” occidentali.
Il volume contiene saggi di F.Berti su Vassilij Grossman; di Pondrano Altavilla su Albert Camus; di Mastrolia su Bertrand Russell; di Pellicani su Simone Weil e Raymond Aron; di Ocone su Benedetto Croce; di Nicotera su Ortega y Gasset; di Bedeschi su Norberto Bobbio; di Cristin su Edmund Husserl; di Cotroneo su Jacques Ellul; di G. Berti su Guglielmo Ferrero; di Orsini su Filippo Turati; di Pecora su Gaetano Salvemini; di Truppi su Milovan Gilas; di Viti Cavaliere su Hannah Arendt; di Cubeddu su Friedrich von Hayek; di Fenizi su Ignazio Silone; di Infantino su Ludwig von Mises; di Breschi su Rodolfo Mondolfo; di Giordano su Edgar Morin; di Campa su George Orwell; di Antiseri su Karl Popper; di Tedesco su Carlo Rosselli.
Detto ciò si pone il problema di definire quali sono queste istituzioni e che cos’è una “società aperta”. In prima approssimazione si può dire che essa è il prodotto di un doppio processo, quello di modernizzazione e quello di secolarizzazione. Dove per modernizzazione deve intendersi la frammentazione del potere politico, sia in senso orizzontale, a favore di altri poteri pubblici (è la divisione dei poteri di Montesquieu) sia in senso verticale, a favore di una pluralità di ambiti privati, come la società civile ed il mercato. In questo senso, dire modernizzazione significa dire libertà dei moderni, e cioè, secondo la definizione di Benjamin Constant, il “godimento pacifico dell’indipendenza privata e il perseguimento dei nostri interessi particolari”[1]. Ed è tale libertà che consente che quei tanti diversi universi, fatti di infinite sensibilità, idee, ambizioni, passioni, che sono in ogni essere umano, possano vedere le luce. Ed è tale libertà la scaturigine della grandezza dell’Occidente. In sintesi, per modernizzazione deve intendersi la contrazione della cogenza normativa del potere pubblico e del suo “ambito di competenza” e la concomitante esplosione dell’individualismo.
La stessa logica è sottesa al processo di secolarizzazione, con il quale si deve intendere la contrazione della cogenza normativa del sacro dall’ambito pubblico a quello privato. O, per dirla diversamente, “la progressiva dilatazione della sfera del profano a scapito della sfera del sacro. Il che può avvenire solo nella misura in cui la società civile acquista, a petto delle istituzioni politiche e ierocratiche, un certo grado di autonomia, grazie alla quale può svilupparsi secondo le sue tendenze spontanee”[2].
Il prodotto creato da questi due processi è pertanto un’articolata e complessa architettura di diritti (lo Stato di diritto), capace di imbrigliare il potere, sia esso politico o religioso, e tutelare l’individuo e gli ambiti nei quali può esplicarsi la sua personalità e creatività. Di qui la necessità vitale di tutto il rosario delle libertà liberali, dell’istituto della separazione dei poteri, della nomocrazia, della democrazia e della laicità. Data questa architettura di diritti individuali, esistono concrete possibilità che si attivi il meccanismo di una crescita economica autopropulsiva[3].
Tuttavia, seppure essenziale, lo Stato di diritto non è sufficiente a garantire la stabilità e il progresso continuo di una “società aperta”. Una tale architettura è, infatti, in grado di dare avvio ad una vera e propria Grande Trasformazione, vale a dire ad una grande fase di espansione economica. Eppure, dopo Piketty e il suo Capitale nel XXI secolo, è ormai appurato che il mercato lasciato a sé stesso produce naturalmente una questione sociale (e cioè polarizzazione economica e l’assenza di ascensori sociali), che se non risolta rischia – come è accaduto nella Roma dei Gracchi e nella Firenze dei Ciompi – di fagocitare tutta la struttura istituzionale che ha dato il via alla fase di sviluppo economico.
Come evitare un tale sbocco pressoché naturale? Storicamente lo strumento più efficace per curare una questione sociale si è rivelato lo Stato sociale, che è in grado di prevenire lo sfarinamento del ceto medio e forniree gli strumenti necessari alla mobilità sociale.
C’è di più. Se Julian L. Simon ha ragione quando sostiene che in fin dei conti la risorsa più importante per un paese sono i suoi cittadini (e le menti di quei cittadini), allora vuol dire che sarà più ricco e prospero quel paese nel quale il più ampio numero di persone gode di buona salute ed ha un livello di istruzione quanto più elevato possibile[4]. Anche in questo caso, uno strumento essenziale per raggiungere questi obiettivi è quello dello Stato sociale, attraverso l’istituzione di un sistema sanitario nazionale gratuito ed universalistico ed una scuola pubblica.
Ciò significa che può aspirare ad un grado elevato e durevole di benessere quella “società aperta” capace di garantire i diritti liberali, prodotti nei secoli dalla tradizione liberale, e i diritti sociali, frutto delle lotte degli ultimi duecento anni dei movimenti operai e sindacali, siano essi di estrazione laica o religiosa.
Il frutto di questa conciliazione tra diritti liberali e diritti sociali, tra libertà liberali e libertà socialiste, tra libertà e giustizia, non è altro che il socialismo liberale. Ciò pertanto vuol dire che è aperta (e continuerà ad essere aperta ed inclusiva) quella società in grado di conciliare socialismo e liberalismo.
A questo punto una precisazione riguardo al socialismo liberale va fatta. Si badi che il socialismo liberale è un metodo, non un insieme di verità. Parte dal presupposto che sia lo stato che il mercato possono sbagliare, di qui la necessità costante di dosarne la presenza. Ma non indica una ricetta valida sempre e per sempre. Non una prescrizione precisa, ma un invito al buonsenso. Non una verità, ma un insieme di consigli, come la necessità di allargare il perimetro delle libertà liberali a tutti gli esseri umani, per far sì che quelle promesse di libertà e di felicità non si tramutino in parole vuote fosse anche per un solo essere umano.
La “società aperta”, dunque, è il prodotto del processo di modernizzazione e secolarizzazione, il che vuol dire che la vita del cittadino della “società aperta” non è scandita più dal sacro. Tuttavia si commetterebbe un errore a considerare una società così concepita come il regno del relativismo, dove vige incontrastato il principio del tutto falsificabile, dovuto alla perdita di ogni idea assoluta di verità, sia essa di tipo politico o religioso.
Una società, infatti, senza un insieme condiviso di valori, percepiti e vissuti come assoluti e non falsificabili, non può esistere. Rischia di tramutarsi nel suo opposto e cioè in una schiera di stiliti muti o in quell’ossimoro, su cui si sofferma a riflettere lo stesso Popper, che è la “società astratta”[5].
Pertanto, perché ci sia società c’è bisogno di un nucleo di valori, percepiti e vissuti come sacri, saldi, non falsificabili.
Qual è dunque la fede della “società aperta”? Tale fede la si può individuare solo ad una condizione. Vale a dire assumere che Popper abbia costruito la sua idea di “società aperta” replicando a livello politico ed istituzionale la struttura del suo metodo scientifico. Tale struttura, infatti, si compone di due parti. Una fatta di principi assoluti e immodificabili ed una, per così dire, procedurale.
La prima parte ha come fondamento il razionalismo critico, che non è in grado di spiegare la scelta di affidarsi alla guida della ragione, Infatti, “né l’argomentazione logica né l’esperienza – le parole sono di Popper – possono di per sé dare vita all’atteggiamento razionalista, infatti saranno sensibili ad esse soltanto coloro che sono disposti a prendere in considerazione l’argomentazione o l’esperienza e che quindi hanno già adottato questo atteggiamento”[6].
In altre parole, “un atteggiamento razionalistico dev’essere già preventivamente adottato e se si vuole che l’argomentazione e l’esperienza risultino efficaci, e quindi non può esso stesso essere fondato sull’argomentazione o sull’esperienza[7]. Tuttavia da Kant in poi sappiamo che ciò che non è fondato sull’esperienza e sull’argomentazione è metafisica e la ragione è impossibilitata a dimostrare razionalmente un assunto netafisico. Per poter fare affidamento su un assunto metafisico è necessario un atto di fede.
Questo significa che perché si possa avere un atteggiamento razionalistico non si può che partire da un “atto di fede dalla fede della ragione” [8]. Ed è una fede , è bene precisare , che non può che essere assunta come incontrovertibile, quindi infalsificabile. Questo è il primo scoglio saldo, un punto fermo, nel mare del tutto falsificabile. Ma ciò apre la strada a un ulteriore passo.
E’ vero che l’etica non è una scienza, ma perché possa esistere la scienza e quindi una comunità di persone che fanno scienza, è necessario che vi sia una “una base etica della scienza e del razionalismo”[9]. E qual è questa base etica? Per fare qualche esempio: la necessità di porre come incontrovertibile l’idea che esista una realtà esterna ed indipendente dalla nostra mente, che questa sia ordinata razionalmente e che tale realtà sia comprensibile ad una mente umana e che questa, a sua volta, e lo abbiamo accettato per fede, sia in grado di elaborare teorie razionali. E poi ancora, l’idea che fare scienza sia cosa buona e giusta, e la convinzione che il fare scienza possa contribuire al progresso dell’umanità. Inoltre, e questo è un punto essenziale, si assume la necessità del progresso, dato che, sostiene Popper, è sempre possibile tra due teorie scegliere quale di esse è migliore e con un più alto potere esplicativo. Questa è la fede secolare della città della scienza.
Tutte queste asserzioni devono essere vissute come non falsificabili, in caso contrario non vi può essere scienza: “senza la convinzione che con le nostre costruzioni teoriche – le parole sono di Albert Einstein – sia possibile raggiungere la realtà senza la convinzione nell’intima armonia del nostro mondo, non potrebbe esserci scienza. Questa convinzione è, e sempre sarà, il motivo essenziale della ricerca scientifica”[10]. Ciò significa che, per usare le parole di Kant, “la sapienza della natura, che meriti propriamente questo nome, presuppone in primo luogo la metafisica della natura”[11].
Pertanto, il metodo scientifico di Popper si compone di due parti, una prima fatta di assunti che affondano le loro radici in un atto di fede, in una scelta a-razionale, e una seconda parte, procedurale: il metodo scientifico vero e proprio.
Visto che si è assunto che vi è una corrispondenza tra la struttura del metodo scientifico e quello della “società aperta”, bisogna provare ad individuare il fondamento metafisico su cui si regge quest’ultima.
Dunque, in cosa consiste il nucleo di valori immodificabili di una “società aperta”? In primo luogo, scrive Popper “nella fede nella ragione, nella libertà e nella fratellanza di tutti gli uomini: la nuova fede e, io credo, la sola fede possibile della società aperta”[12]. Si è fatto un ulteriore passo in avanti: la “società aperta” ha scolpiti nella propria costituzione la fede nella ragione, la fede nella libertà e nella fratellanza e quindi il principio evangelico-kantiano degli altri come fine e mai come mezzo. Ma non basta.
Perché una “società aperta” possa stare in piedi deve aver costituzionalizzato la fede nell’uomo, o meglio la certezza che l’agire umano possa tendere al progresso e al miglioramento dell’esistenza, così come prescrive la prima parte della struttura del metodo scientifico, che di fatto è la norma che regola l’attività di coloro che fanno scienza.
La “società aperta”, pertanto, deve vivere come una certezza la capacità che l’azione umana possa fare in modo che il domani sarà migliore rispetto al passato: la fede nel progresso umano e quindi la fede nella capacità di poter “padroneggiare l’avvenire”[13]: “E` questo ciò che ha sostituito la statica economica della società tradizionale – curtense o di sostentamento – dove il domani sarà identico all’ieri”[14]. Evaporata così la fede trascendente, gli uomini della “società aperta”, per impedire che questa si trasformasse in una società astratta, hanno bisogno di innalzare sugli altari della fede pubblica un nucleo di valori del tutto secolari ma vissuti in maniera del tutto sacra: vale a dire la fede nell’uomo, quale creatore di un mondo nuovo, in grado di produrre progresso. A tale proposito Alain Touraine scrive: “tutte le società si sacralizzano, ma le società europee hanno attinto la propria sacralità da se stesse. Essa non poggia né su un dio né sul movimento della storia e ancora meno su una situazione definita in termini naturali; la morale che elabora e che insegna è puramente civica”[15].
Umanesimo e quindi fede nel “progresso indefinito” inteso come, le parole sono di René Guénon, “una specie di dogma infallibile e indiscutibile”[16], sono i cardini del credo laico della “società aperta”. Questa idea di progresso è un elemento importante per leggere un aspetto particolare dei totalitarismi che dilanieranno la storia del XX secolo, vale a dire il consenso di massa di cui hanno goduto.
Partiamo da un punto. Di per sé ogni società produce un numero più o meno ampio di individui anomici e la “società aperta” occidentale non sfugge a queste regola. Anzi, se possibile essa produce fisiologicamente un numero più ampio di individui anomici rispetto alle società tradizionali: “sin dai suoi primi vagiti – scrive Pellicani – il modo di produzione capitalistico ha operato come un generatore permanente di anomia e di alienazione”[17]. E questo perché il processo di secolarizzazione, la disintegrazione della società chiusa, e il processo di modernizzazione ed in particolare una parte di esso, lo sviluppo economico, che genera (se non bilanciato) pochi vincitori e molti perdenti, producono il rigetto dei valori e della fede laica della “società aperta” e generano il desiderio di riannodare il cordone ombelicale, di ricucire la confortevole placenta della società chiusa.
In altre parole, la “società aperta” genera fisiologicamente individui anomici: sono gli orfani di Dio, i profughi della società chiusa, che provano disgusto nei confronti dei valori laici e secolari che reggono una “società aperta”, ed orrore verso la vacuità dei riti democratici (il potere che perde ogni sacralità e diviene il risultato di una semplice somma aritmetica) e sono animati da un odio profondo nei confronti della modernità ed in particolare della borghesia, che del resto “è l’altro nome della società moderna” e che per questo è “da sempre il bersaglio comune per tutti gli infelici della modernità”[18]; e del capitalismo che “più che la creazione d’una classe è la creazione di una società nel senso più globale del termine”[19]. Costoro “provano un violento disgusto per tutti i valori esistenti”[20], valori che a loro appaiono come esclusivamente il prodotto della “mentalità e dei principi morali della borghesia”[21].
Odiano in altre parole gli agenti – borghesia e capitalismo – che hanno dissacrato la società chiusa hanno “ucciso Dio” e hanno fatto evaporare dal mondo la certezza di un senso immanente, di un fine ultimo, e di qualsiasi ordine metafisico. Odiano questi agenti di modernizzazione e di secolarizzazione perchè portatori sani del virus che ha infettato le società sacre tradizionali, la ragione, con la quale non si può dimostrare un sacro metafisico.
Di qui la reazione, vale a dire la condanna senza appello dell’esistente e il tentativo di portare a compimento una palingenesi totale, il rivolgimento del mondo capovolto. Si tratta, in altre parole, di riportare indietro le lancette della storia e forgiare una nuova società tradizionale retta da una nuova tradizione sacra e trascendente. Si badi che questa è l’ambizione di tutti i nemici della modernità e della “società aperta”, dai totalitarismi politici del XX secolo a quelli religiosi (ISIS) del XXI secolo. Tutti animati dallo stesso odio nei confronti della modernità occidentale e nei confronti degli agenti della modernizzazione, di coloro cioè che hanno “dissacrato” il mondo, vale a dire la ragione dei philosophes, la borghesia e dunque il capitalismo.
C’è però un punto da chiarire. Se fisiologicamente il processo di modernizzazione e di secolarizzazione produce anomici e le loro voci di condanna, perché in alcuni periodi storici ci sono più orecchie che ascoltano le loro grida di dolore e prestano fede ai loro appelli palingenetici?
La risposta è nella fede della “società aperta”. Finchè i valori laici della “società aperta” imperano, le analisi e i programmi, le invettive e le scomuniche degli anomici restano voci di singoli nel deserto. Tuttavia può accedere che eventi traumatici spacchino il nucleo della fede laica della “società aperta”. Se ciò accade, questa si disintegra e i suoi cittadini diventano una massa sbandata, impaurita e angosciata, in cui gli uomini perdono “definitivamente il loro posto nell’universo”[22]. Una “società aperta” si trasforma così – le parole sono di Hannah Arendt – in una “società atomizzata”[23].
A questo punto, visto che nessuno può vivere senza una fede che dia un senso al futuro, le coscienze collettive entrano in sintonia con le voci dei profeti del deserto, ne vivono lo sconforto e lo smarrimento per la perdita della fede, sono costrette a prendere atto, come per la prima volta, della morte di Dio e diventano sensibili agli appelli palingenetico-reazionari.
Se così stanno le cose, allora è necessario domandarsi quali siano gli eventi che hanno frantumato quel nucleo di verità della “società aperta”, dalla cui fusione, per reazioni a catena, si sono generati i totalitarismi del XX secolo? Quali sono gli eventi che sconsacrando la fede secolare della “società aperta” europea hanno consentito ad individui anomici e marginali (si pensi alla parabola del fondatore del nazismo) di entrare in sintonia con le coscienze di un intero popolo?
Il principale di tali eventi traumatici è la Prima guerra mondiale e la trincea. Milioni di esseri umani, nelle trincee, su opposti fronti, sono andati a scuola di nichilismo: “la guerra, scrive Overy, per chi ebbe la ventura di viverla sino in fondo, si rivelò qualcosa di macabro, sporco, abbrutente, un deserto morale. […] Fu una conferma della premonizione nietzschiana del declino, dell’evoluzione in negativo”[24]. E ciò significa la confutazione dell’idea di progresso, dell’evoluzione in positivo.
Gli orrori di massa di quella guerra divenivano la sentenza di condanna di un’intera civiltà. La più brillante e sfavillante civiltà della storia aveva prodotto quegli orrori. Lo sviluppo tecnologico e l’avanzamento scientifico, vanto della civiltà europea, erano serviti alla industrializzazione dell’omicidio, o meglio, della “morte organizzata”[25], per usare le parole di Mosse.
E’ pertanto in quelle trincee, di fronte agli occhi di milioni di uomini, che si frantuma la fede della “società aperta”. E’ in quelle trincee che svanisce la fede nel progresso: “l’orrore del periodo bellico, i gas, le bombe, la fame rivelarono lo spessore esiguo della vernice che la civiltà poteva rappresentare”[26].
La trincea, pertanto, traduce per le masse il nichilismo di Nietzsche, annuncia a milioni di uomini la morte di Dio e nel contempo mostra a tutti a quali orrori la civiltà europea aveva condotto, vale a dire lo stermino di massa grazie ai progressi della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica. E’ in quelle trincee che i valori della “società aperta” europea vengono falsificati. Il risultato è uno sradicamento immediato e collettivo che dà via al processo di atomizzazione. Un processo dal quale interi popoli sbandati usciranno trovando un senso nelle voci di quanti spinti dall’odio avevano dichiarato da decenni guerra a quella civiltà che aveva gettato milioni di persone in quelle trincee e intendevano rifondarla ab imis fundamentis.
“Quando la Grande Guerra cessò – scrive Emilio Gentile – l’uomo moderno aveva perso l’orgoglio della propria superiorità, era angosciato dalla visione di un futuro senza speranza, dove la nozione stessa dell’uomo moderno quale elevata espressione di una superiore civiltà era stata brutalmente annientata dall’esperienza della guerra. L’uomo europeo, l’uomo della modernità, nel momento dell’apoteosi della sua civiltà, si era rivelato un barbaro capace di inumana ferocia”[27]. “Noi, le civiltà, ora sappiamo che siamo mortali”, scriveva Paul Valery, “noi ora sappiamo che l’abisso della storia è grande abbastanza per tutti. Sentiamo che una civiltà è fragile come una vita”.
È la trincea che fa sorgere il dubbio che ci possa essere qualcosa di marcio in quella civiltà, che la votasse alla distruzione più che al progresso: scriveva Albert Schweitzer “è chiaro a tutti che la morte della civiltà è data dal tipo del nostro progresso. Ciò che rimane non è più saldo, resta in piedi perché non è stato ancora esposto alla pressione che ha fatto cadere il resto ma, costruito com’è sulla ghiaia, facilmente verrà trascinato via alla prossima frana”[28].
È la trincea che, distruggendo il futuro immaginato, stura le orecchie di milioni di uomini e li prepara ad ascoltare la voce degli orfani di Dio che da decenni predicano inascoltati. E’ la trincea che produce masse disorientate di uomini che hanno bisogno come l’aria di una fede in cui credere.
Se così stanno le cose allora aveva ragione Benedetto Croce quando sosteneva che le reazioni rivoluzionarie del fascismo e del nazismo nacquero da “uno smarrimento di coscienza, una depressione civile e una ubriacatura, prodotta dalla guerra”[29]. Nel consenso a quei totalitarismi ci sono, pertanto, anche ragioni esistenziali e di fede: “Il fascismo e il nazismo furono un fatto o un morbo intellettuale e morale – continua Croce – , non già classistico ma di sentimento, di immaginazione e di volontà genericamente umana, una crisi nata dalla smarrita fede non solo nel razionale liberalismo ma anche nel marxismo, che era a suo modo razionale sebbene materialistico […]”; è per questo che l’appello fascista riuscì a conficcarsi “nel vuoto che si era aperto nelle anime, nella depressione della volontà” conquistando così la “fiducia delle masse”[30].
Pertanto non è un caso se a partire dalla prima guerra mondiale, che ha avuto l’effetto di frantumare la fede della società aperta nell’uomo quale creatore di progresso, la “società aperta” liberal-democratica occidentale, dopo aver riempito di sé il mondo, viene messa sotto attacco ad opera di nemici interni ed esterni e di tutti quanti avvertono come insostenibile il disagio di una civiltà individualista e secolare. Di qui l’importanza di quanti difesero questa civiltà (i difensori dell’Occidente per l’appunto) dagli attacchi di quanti (“proletariato interno” e “proletariato esterno” nell’accezione di Arnold Toynbee) miravano a radere al suolo e cancellare quella che nella storia dell’umanità è a tutti gli effetti una vera e propria anomalia, tanto che, pur con qualche approssimazione, nella categoria della “società aperta” possono storicamente annoverarsi solo quattro casi: la democrazia ateniese, la repubblica romana, i liberi comuni medievali e la “società aperta” nella quale una parte del mondo attualmente vive.
Tirando le somme: ogni qual volta la fede nell’uomo e nel progresso, in un domani migliore rispetto all’oggi, vacilla, quando le aspettative collettive vengono deluse, allora le fondamenta di una “società aperta” tremano: sono le emozioni, per dirla con Moïsi, e le rappresentazioni del futuro che esse generano, che contano: è la paura di aver perso il “controllo sul futuro”[31]. Ed il futuro, quale luogo dove si realizzano le “magnifiche sorti e progressive” dell’umana gente, è l’equivalente della tradizione per una società chiusa. E’ il perso su cui tutto si regge.
La “società aperta” è, pertanto, come una trottola: finché gira vorticosamente (una continua Grande trasformazione, che alimenta continuamente la fede nell’uomo creatore di mondi nuovi e di continuo progresso) la trottola sta in equilibrio su un perno (la sua fede secolare), se smette di girare tutto crolla. Pertanto la crisi (anomia di massa e consenso ai movimenti palingentico-rivoluzionari) non è l’effetto della Grande trasformazione né dei mutamenti che essa provoca, ma il frutto della convinzione che essa stia per finire e con essa la realizzazione delle aspettative crescenti. La presa d’atto angosciante, cioé, che “che il futuro non è più quello di una volta” per dirla con Paul Valery, che, cioè, il futuro sarà peggiore rispetto a quello al quale ci si era abituati a pensare e che si credeva spettasse di diritto.
La fine della guerra, il ritorno del benessere, la sconfitta del comunismo sovietico, lo straordinario sviluppo tecnologico dei nostri giorni, hanno certamente rinsaldato la fede laica della “società aperta”, ma sotto la cenere quel bisogno di verità assolute, ultra-umane ed ultramondane, continua a persistere. Il perché lo chiarisce Popper: “questa civiltà non si è ancora totalmente ripresa dallo shock della sua nascita; il passaggio cioè dalla società tribale o società chiusa, con la sua sottomissione alle forze magiche, alla società aperta che libera le capacità critiche dell’uomo”[32].
Tale “shock di passaggio è uno dei fattori che hanno reso possibile l’emergere di quei movimenti reazionari tesi a rovesciare la civiltà per tornare al tribalismo. Ed esso rivela pure che quello che noi, oggigiorno, chiamiamo totalitarismo appartiene a una tradizione che è altrettanto vecchia o altrettanto giovane che la nostra stessa civiltà”[33].
Ciò spiega il successo di quegli intellettuali che, andando a toccare le ferite ancora non rimarginate dovute alla perdita dell’antica fede, riescono a suscitare forti passioni e ad ottenere enormi consensi. E’ la critica costante nei confronti degli agenti della secolarizzazione, la fredda ragione che non sarebbe in grado di spiegare le forze più profonde (e misteriose) che muovono l’uomo; il capitalismo, che con il suo culto del denaro “ha avvilito tutti gli dei dell’uomo e li ha trasformati in merce”[34]; gli Stati Uniti, emblema (a loro dire) di un Occidente che vive sperperando ciò che ha rubato ai poveri.
Un Occidente che può redimersi solo riscoprendo una dimensione sacra, aprendosi alla ricerca dell’assoluto, di una nuova spiritualità, abbandonando gli dei falsi e bugiardi della ricerca del benessere e del progresso. Sono tutti punti che ritornano sempre in tutti questi moderni cattivi maestri, cantori della “società chiusa”, oracoli di oscuri saperi iniziatici, il cui messaggio è essenzialmente di natura reazionaria. Feroci critici della modernità dalla quale però sanno trarre abbondanti frutti.
Del tutto diversa la sorte degli autori che sono qui raccolti. Essi sono gli intellettuali che plasmano la “società aperta” e pertanto non hanno verità da propalare, se non quelle laiche e secolari che conosciamo. La loro fede è del tutto prosaica, non vibra del calore della lirica, non ha l’epos delle grandi narrazioni, non assegna compiti salvifici a nessun uomo, né classe, né nazione.
Quell’intellettuale ha fede nell’uomo e nella forza della ragione nel creare progresso e benessere, ma crede sia necessario un governo ed un ampio sistema di leggi, nonché la violenza razionale, per impedire che quello stesso uomo si trasformi in un incubo per altri essere viventi. Ha fede nella scienza quale forza creatrice, ma è consapevole delle enormi capacità di distruzione che la scienza stessa ha. Quell’intellettuale ha la consapevolezza che un senso di fratellanza lega davvero tutti gli uomini, uguali non perché tutti mortali, ma perché tutti vivi esclusivamente per un piccolo lasso di tempo, e pertanto mossi, essenzialmente, dagli stessi sentimenti e dalle stesse aspirazioni. Ma ha anche la consapevolezza che quella stessa forza può essere causa di separazione: è il nazionalismo, l’odio etnico, le faide familiari e claniche.
Quell’intellettuale, dunque, non solo non ha verità eterne ed epiche da propalare, ma sa anche che le sue verità laiche, in sé, se non bilanciate e corrette, contengono i germi della violenza e della distruzione, oltre che quelle del progresso e della pace.
C’è un’altra considerazione da fare. Il passaggio dalla “società chiusa” alla “società aperta”, vale a dire dalla onnipervasività della cogenza normativa del sacro e dall’assolutismo della tradizione, alla laicizzazione della fede non è un evento storico che si compie una volta per tutte. Ma si tratta di un processo che si compie in ogni essere umano nel corso della sua esistenza. Ed è un processo che può avere un esito positivo, vale a dire la presa d’atto che ogni assoluto non è che una falsa credenza, o al contrario, il rifiuto di una così laica, “troppo umana” visione del mondo, e il tentativo titanico (ed inutile) di ricostruire una verità assoluta. In sintesi, il passaggio dalla “società chiusa” alla “società aperta” è sì un fenomeno storicamente determinato (non irreversibile) ma è anche un passaggio esistenziale che si compie nella vita di ogni essere umano[35].
Se ora si prendono tutti questi punti (modernizzazione; socialismo liberale; secolarizzazione e fede laica) e attraverso di essi si cerca di guardare agli autori le cui vite ed opere sono raccolte in questo volume, si noterà che quasi tutti i punti individuati ricorrono, come un minimo comun denominatore.
E’ forse un caso che molti di loro siano socialisti (democratici e liberali)? E’ forse un caso che tutti siano accaniti critici del potere assoluto? E’ forse un caso che tutti (o quasi) attraversino la drammatica crisi del crollo degli assoluti e che da quella crisi ne escano con un senso profondo di fede nei confronti dell’uomo, della sua fragilità, della sua potenza creatrice, della forza delle libertà?
Ed è forse un caso che siano tutti (o quasi) fieramente soli? Tanti piccoli Davide in lotta contro immense Teogonie. Sono tutti (o quasi) intellettuali che per grossa parte della loro esistenza hanno combattuto da soli senza andare alla ricerca né di consensi né di applausi né di denaro. Sono soli e per giunta percepiti dalle masse come fastidiosi, irritanti quasi come un tafano, come lo fu Socrate, che non si curano di essere considerati dalla propria società come cattivi maestri, consolandosi forse con la consapevolezza che l’uomo buono “è colui le cui opinioni o attività riescono sgradite a chi sta al potere”[36].
Sono intellettuali soli, ma pronti a mettersi contro le loro stesse idee quando queste rischiano di tramutarsi in dogmi. “Per tutta la vita – le parole sono di Russell – ho provato il desiderio di sentirmi all’unisono con grandi masse di uomini, come deve essere per chi fa parte di una folla entusiasta. Il desiderio è stato spesso così forte da indurmi ad ingannare me stesso. Mi sono immaginato di essere ora liberale, ora socialista, ora pacifista, ma nel senso più profondo non sono mai stato né l’una cosa né l’altra né l’altra. Sempre l’intelletto scettico, quando più avrei desiderato che tacesse, ha mormorato i suoi dubbi, mi ha tagliato fuori dai facili entusiasmi e mi ha trasportato in una solitudine desolata. Durante la guerra, pur collaborando con quaccheri, membri del movimento di resistenza passiva e socialisti, pur essendo pronto a accettare l’impopolarità e le noie che sempre accompagnano chi sostiene attivamente opinioni non gradite a tutti, non esitavo a dire ai quaccheri che, secondo me, molte guerre storiche sono state giuste e ai socialisti dicevo che temevo l’instaurazione della tirannia dello Stato. Gli uni e gli altri mi guardavano di traverso e, pur accettando il mio aiuto, non mi consideravano uno dei loro”[37].
Alcuni di loro, per le loro idee, troveranno la morte. Per altri, dopo anni di stenti e finanche dopo il carcere, i riconoscimenti dei contemporanei giungeranno mentre sono ancora in vita (il Premio Nobel a Russell, ad Hayek o a Mises, per fare qualche esempio); altri continuano ad essere ancora oggi minoritari, nell’ombra, in fondo soli, basti pensare ad Ignazio Silone.
Non è detto che sia un male: continuano ad essere vivi, in quanto ancora fastidiosi per le masse, in quanto contrari alle opinioni dominanti, in quando dispensatori di verità scomode. Continuano a fare quello che è il vero mestiere dell’intellettuale, essere cioè letteralmente paradossali.
[1] B. Constant, La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, Einaudi, Torino, p. 32
[2] L. Pellicani, Modernizzazione e secolarizzazione, Il Saggiatore, Milano, 1997, p. 7
[3] Il fatto che esistono società aperte (si vedano a riguardo i più recenti rapporti di Freedom House) povere impone di aggiungere degli elementi in grado di spiegare perché alcune società aperte siano povere ed altri siano invece ricche. Tra gli elementi più importanti credo che sia necessario considerare i seguenti: Stato di diritto e Stato sociale; diritto all’eresia, diritto all’errore, Stato innovatore ed economica di mercato.
[4] J.L. Simon, The Ultimate Resource, Princeton University Press, 1981
[5] K. R. Popper, La società aperta e i suoi nemici, Armando Editore, Roma, 1996, vol. 1, p. 217.
[6] Ivi, vol II, pp. 274–275.
[7] Ivi, vol II, p. 274
[8] Ivi, vol II, p. 275
[9] Ivi, vol II, p. 283
[10] A. Einstein, L. Infeld, L’evoluzione della Fisica, Bollati Boringhieri, Torino 1965, p. 303
[11] I. Kant, Vorrede an Methaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft, in Gesannelse Schriften, vol. V, Berlino 1911, pp. 469-472, citato in D. Antiseri, Ragioni della razionalità, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, vol. I, p. 122.
[12] K. R. Popper, La società aperta e i suoi nemici, Armando Editore, Roma, 1996, vol. 1, p. 228
[13] R. Castel, L’insicurezza sociale, Einaudi, Torino, 2004, p. 35
[14] L. Pellicani, Dalla società chiusa alla società aperta, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002.
[15] A. Touraine, La globalizzazione e la ne del sociale, il Saggiatore, Milano, 2008, p. 66
[16] R. Guénon, La crisi del mondo moderno, Mediterranee, Roma, 2003, p. 17.
[17] L. Pellicani, La società dei giusti, Etaslibri, Milano, 1995, p. 11
[18] Ivi, p. 19.
[19] Ivi, p. 15.
[20] H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 2009, p. 453.
[21] Ivi, p. 454
[22] H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino 2009, p. 458.
[23] H. Arendt, Archivio Arendt, Feltrinelli, Milano 2003, vol. II, p. 127.
[24] R.J. Overy, Crisi tra le due guerre mondiali, il Mulino, Bologna, 1998, p. 10
[25] G.L. Mosse, Le guerre mondiali, Laterza, Roma-Bari 1990, p. 3
[26] R.J. Overy, Crisi tra le due guerre mondiali, op.cit., p. 11.
[27] E. Gentile, L’apocalisse della modernità, op., cit; p. 19
[28] Ivi, p. 22
[29] Citato in R. de Felice, Fascismo: le interpretazioni dei contemporanei e degli storici, Laterza, Roma-Bari 1998, p. 391
[30] B. Croce, Chi è «fascista»?, in R. de Felice, Il Fascismo, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 397-401.
[31] D. Moïsi, Geopolitica delle emozioni, Garzanti, Milano 2009, p. 139.
[32] K. R. Popper, La società aperta e i suoi nemici, op. cit., Vol. I, p. 19
[33] Ibidem
[34] K. Marx, Sulla questione ebraica, in Opere complete, Vol. III, Editori Riuniti, Roma, p. 187
[35] Si veda N. Mastrolia, La grande transizione, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011
[36] B. Russell, Saggi scettici, Longanesi, Milano, 2013, p. 153
[37] B. Russell, Autobiografia, Longanesi, Milano, pp. 51-52, vol. 2

![Decadenza [ FILO ROSSO ]](http://www.filosofia.it/wp-content/uploads/2017/01/419fed1c7d1f3e9b3f1cde2c12a5402b-large-210x120.jpg)
