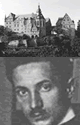Intervista a Costantino Esposito
|
|
Intervista a Costantino Esposito Partiamo innanzitutto da questo dato di fatto: tutto Essere e Tempo, ossia tutto il lavorio, la tessitura che Heidegger fa della sua ricerca attraverso il grande lavoro delle lezioni accademiche, delle conferenze, dei saggi (che soltanto successivamente sono apparsi o confluiti nell’opera maggiore), possiede una segreta forza di gravità, il tentativo ostinato, cioè, di pensare l’essere non più nei termini di una presenza. Pensare l’essere come una presenza significherebbe agli occhi di Heidegger, non solo in questo momento ma nel corso di tutta la sua ricerca, pensarlo ancora determinato in una oggettività di tipo ontico-teoretico. Il suo tentativo è invece quello, come mi sono sforzato di documentare nel mio intervento attraverso il filo dell’Historisches e del Geschichtliches, di ripensare l’essere come alcunché che accade. E forse anche la dizione “qualcosa che accade” non è del tutto esatta, perché non si tratta appunto di pensare alcunché che accada, bensì il puro accadere. Questa mi sembra essere la forza di gravità di Essere e Tempo, la sua tendenza endogena, visto che tutte le strutture dell’opera mirano ad articolare e a radicalizzare questo punto di vista. La Cura stessa, l’essere-per-la-morte, l’estaticità temporale dell’esistenza mirano a connotare il senso d’essere dell’Esserci come qualche cosa che incessantemente si de-presentifica; ma, d’altra parte, questo per Heidegger non significa assolutamente sforzarsi di cercare il significato dell’Esserci in un oltre-mondo, in una Utopia, in una escatologia. Questo è il punto che nella mia relazione non ho avuto modo di affrontare e che Lei giustamente mi ripropone perché è il focus finale delle mie osservazioni. Se, infatti, da una parte, per Heidegger, bisogna ripensare l’essere in qualche modo “liberandolo” dalla presenza, non soltanto dalla cosiddetta mera presenza sottomano, pensandolo come alcunché che non può darsi in presenza, ma in qualche modo deve sempre costruttivamente eccederla, dall’altra parte, però, non c’è un altrove, un altro luogo o un altro tempo rispetto alla presenza; anche il futuro (e perciò la storia è così importante, in quanto rappresenta il nesso tra il destino e l’eredità) non è assolutamente da intendersi in chiave utopica o messianica, in quanto il futuro non è un “non-ancora” che si debba attendere ma è già in qualche modo sempre accaduto come ritorno sulla fatticità. Non essendoci un luogo o un tempo altro dal presente e non potendo l’essere darsi in presenza, il rapporto tra la de-presentificazione e il presente, cioè il rapporto tra questa possibilità e il darsi nella presenza, rimane come segreta aporia, come nodo irrisolto dal quale però non si può non passare. Perciò a mio avviso il problema della storia è particolarmente importante per comprendere il pensiero heideggeriano. Non a caso ho insistito molto sulla storiografia e sulla distruzione, da intendersi non semplicemente come una relativizzazione del presente, visto che non si tratta appunto di cogliere un sovramondo o un piano di valori intemporali rispetto al transeunte, al contingente, al relativistico, ma di trovare nel presente lo scarto rispetto al presente. 2. La possibilità di cui parla Heidegger, dunque, non è da intendersi in senso modale, cioè come una possibilità che manchi della realizzazione. Si tratta di una possibilità che rimane, per così dire, in atto come possibilità e che non passa mai all’atto nel senso della realizzazione. Questa presenza di una certa attualità nella potenza avvicinerebbe, secondo alcuni interpreti, Heidegger ad Aristotele, il quale, come si sa, sostiene il primato dell’atto rispetto alla potenza. Cosa ne pensa di questo accostamento? Dobbiamo dire che in qualche modo uno scarto oggettivamente c’è. Da un certo punto di vista, e sulla scorta di alcune interpretazioni speculative che sono state tentate, si potrebbe dire che il modo in cui Heidegger interpreta Aristotele, proprio in virtù di un innegabile primato della “possibilità” rispetto alla “realtà”, segnerebbe la preminenza della potenza sull’atto. Tuttavia, ad un livello storico-critico, non si può non evidenziare una differenza. Comunque lo si voglia curvare, il primato dell’atto rispetto alla potenza in Aristotele è un dato che si impone; non così in Heidegger, dove, al contrario, emerge questa fortissima idea di una possibilità che permane, liberata naturalmente dal suo significato modale, e rimane come il nascosto e irrisolvibile accadere dell’essere, che è un accadere senza presenza: un accadere che non soltanto non prelude ad una realizzazione, ad un telos, in cui possa realizzarsi, ma che è esso stesso il compimento, l’unica possibile realizzazione, un evento senza fatto. In questo io vedo un filo rosso che accompagna e che attraversa tutte le svolte (con ciò non intendo dire che Heidegger abbia pensato sempre alla stessa maniera) e che rivela come la filosofia heideggeriana presenti alcuni elementi in qualche modo invarianti, che poi vengono ripensati in contesti diversi, venendo poi magari maggiormente sottolineati. Di certo, però, uno di questi elementi invarianti nel pensiero heideggeriano, e che io tentavo ieri di seguire attraverso il concetto dell’accadere e della storicità, è rappresentato proprio dall’idea che la possibilità è qualcosa che si rifiuta al reale e alla realizzazione. Ciò che, in pratica, rimane impensabile, impossibile per Heidegger è che qualche cosa che si realizza possa custodire in sé il possibile; paradossalmente, per essere molto ‘ontici’ nella dizione, si potrebbe dire che la domanda sull’essere prima o poi è destinata a diventare in qualche modo alternativa alla domanda sull’ente: quando chiedo dell’essere, non posso che in qualche modo sospenderlo come possibilità irrealizzabile rispetto agli enti, e quando chiedo degli enti, non posso che necessariamente aver dimenticato la verità dell’essere. Quello che così diventa impensabile e impossibile per Heidegger è il chiasmo tra il senso o la verità dell’essere e l’ente stesso; è come se l’ente non fosse più capace di portare il segno dell’essere, come se diventasse opaco, non riuscisse più a dire l’essere. Come si sa, infatti, sebbene in Essere e Tempo ci sia un ente che viene interrogato perché risponda alla domanda sul senso dell’essere, questa risposta viene interrotta, diventa appunto (l’)impossibile. 3. Cerchiamo ora di interagire virtualmente con la tesi di von Herrmann secondo la quale la metaontologia di cui Heidegger parla nell’ultimo corso marburghese del 1928 sarebbe una ontologia regionale. Proprio in quel corso Heidegger definisce l’oggetto della metaontologia, cioè to theion (il divino), come das Umgreifende und Überwältigende (l’onniabbracciante e l’incombente), das Übermächtige (l’onnipotente). Determinazioni che non sembrano riportare a nulla di regionale. Mi pare che Lei non sia d’accordo con questa lettura di von Herrmann… Non è solo una questione tra me e von Herrmann ma è una questione sulla quale sono state spese pagine e pagine di commentari medievali e rinascimentali nella storia dell’aristotelismo e in cui si è spesa tutta la filosofia araba e tutta la filosofia latina. C’è appunto un nesso tra la prote philosophia (ontologia fondamentale) e la theologike episteme (metaontologia); ma come bisogna intendere questo timiotaton genos, questo genere supremo? In fondo si tratta pur sempre di un genere, sebbene certamente supremo. Giustamente Lei dice, è il genere supremo e sembrerebbe strano che esso rappresenti solo un genere fra gli altri; tuttavia, rispetto all’altro oggetto della metafisica, che è lo on e on, il katholou, e che accoglie tutto al suo interno, il divino rimane solo un genere dell’essere. Dunque, prospetticamente, per quanto possa sembrare strano visto che ci riferiamo al divino, dobbiamo dire che si tratta di una ontologia regionale. Su questo bisogna poi fare un passo indietro e rivolgerci a Suarez (Heidegger si è occupato di questo pensatore nel corso del 1927, I problemi fondamentali della fenomenologia, e in quello del 29-30, Concetti fondamentali della metafisica. Mondo, finitezza, solitudine) con il quale la considerazione di Dio diventa in qualche modo un aspetto inferiore dell’ontologia. L’ontologia tratta dell’ens ut sic, dell’ens in quantum ens, che è una nozione mentale in qualche modo, una pura fictio noetica, che ha i suoi inferiora e tra questi inferiora c’è anche il concetto di Dio. Allora, teologicamente o fisicamente, il concetto di Dio è naturalmente il concetto primo perché Dio ha creato l’uomo che pensa, ma, noeticamente parlando, il concetto di Dio è inferiore al concetto di ente, perché noi dobbiamo avere prima il concetto di ente per poter pensare Dio come un ente particolare. Da questo punto di vista, dunque, si capisce in che modo von Herrmann poteva dire che l’articolazione tra prote philosophia e theologike episteme, in qualche modo, ma sottolineerei molto questo “in qualche modo”, prefiguri l’articolazione tra ontologia fondamentale e metaontologia. Detto questo, in una battuta, io credo che al di là di un programma sistematico, Heidegger non abbia poi sviluppato e attuato questa metaontologia. Mi sembra forse un po’ debole l’argomentazione di von Herrmann secondo la quale nel frattempo urgevano nuove istanze teoretiche legate ai Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis); la ragione potrebbe essere, piuttosto, che questo ritorno dalla fondazione ontologico-esistenziale alla ontica metafisica finisce per stridere con la radicalità dell’istanza di de-presentificazione tipica della ontologia fondamentale e, come mi permettevo di richiamare nella mia domanda a von Herrmann, il punto non è tanto che si ritorni dalla fondazione ontologico-fondamentale all’ontica metafisica, ma che si tratti di una continua oscillazione dall’essere all’ente. Dunque, anche quando si va all’ente bisogna subito allontanarsene di nuovo e de-presentificarlo, perché se si continua a considerarlo come ente diviene subito l’oggetto delle scienze positive. 4. Sempre nell’ultimo corso marburghese del 1928, Heidegger paragona la scienza dell’essere e la scienza del divino alla diade di esistenza ed essere-gettato. Quest’ultimo concetto di Geworfenheit riporta al tratto più finito del Dasein, quello per cui l’Esserci non si è portato da se stesso nella comprensione dell’essere. A questa finitezza Heidegger sovrappone il concetto teologico dell’esser-creato…. Innanzitutto è interessante questo: anche il problema dell’essere-creato viene interpretato da Heidegger come un problema tipico di un’ontologia regionale. Accusiamo questo colpo nell’impostazione del problema. Il problema della derivazione, della provenienza dell’essere non è più una questione che pertenga al senso dell’essere in generale; da un certo punto di vista esso si dà in maniera assolutamente autoreferenziale. In questo senso, mi viene in mente che non tanto il rapporto tra potenza e atto, ma proprio il concetto aristotelico di physis è in questo caso normativo. Che cosa sono i physei onta? Sono quegli enti che hanno in sé il principio del movimento. Heidegger ne parla en passant nel corso del 1924 su Aristotele (Die Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie). Pur non soffermandosi molto su questo tema, mi sembra di non tradire la sua intenzione se unisco la intenzionalità ontologica heideggeriana di questi anni a quella idea fondamentale della physis, dei physei onta. L’idea consiste proprio in questa radicale autoimmanenza del principio, in questa totale presenza endogena del principio del movimento, di modo che l’esser-creato diventi un problema di ontologia regionale, cioè dell’eventuale considerazione del rapporto tra l’ente primo e gli enti creati (che sono in qualche modo già un secondo livello rispetto al pensiero dell’essere in generale). D’altra parte sappiamo bene che anche in anni successivi a Essere e Tempo, Heidegger ha sempre detto che noi non possiamo originariamente pensare gli elementi fondamentali di qualsiasi teologia se non ripensiamo preventivamente il senso originario dell’essere stesso. Anche qui, però, noto il problema. Così come prima dicevo che il punto è di pensare un accadimento che non si può mai dare in presenza: qui la vera posta in gioco secondo me viene concentrata da Heidegger sul concetto di “dato”. Cosa significa che qualcosa è “dato”? Anche nella nostra lingua, il termine “dato” è innanzitutto il participio passato di un verbo. “Qualcosa è dato”, noi normalmente lo intendiamo come un prodotto finale, come qualcosa che è qui presente a disposizione, sottomano. Ma nella parola stessa vibra una provenienza: qualcosa è dato perché proviene, mi è stato dato. Heidegger sa bene tutto questo, ma il suo tentativo è di pensare questo “dato” senza un donatore e senza un donato, di pensare questo dato come una pura donazione senza un terminus a quo e senza un terminus ad quem, perché in entrambi casi la donazione ricadrebbe in due poli ontici, e quindi per lui accadrebbe un corto-circuito e si azzererebbe l’enigma, la profondità e il mistero dell’essere. 5. Pensare l’essere come una pura donazione senza un terminus a quo e senza un terminus ad quem richiama la celebre definizione dell’Esserci che Heidegger effettua in Essere e Tempo: nullo fondamento di una nullità. In questa struttura negativa della costituzione d’essere dell’Esserci mi pare rientri anche il concetto di libertà… La cosa è molto complessa. Io mi sono occupato di questo problema in un libro sulla interpretazione che Heidegger ha dato di Schelling, intitolato Libertà dell’uomo e necessità dell’essere. Heidegger interpreta Schelling. Heidegger parte da un’idea in qualche modo assolutamente cristiana della libertà (si pensi alla frase dal vangelo di Giovanni, die Wahrheit wird euch frei machen). Quando nell’Essenza della verità (Vom Wesen der Wahrheit), dice che l’essenza della verità è la libertà e che la libertà è il lasciar-essere l’ente, stacca la libertà dal mero esercizio della volontà e intende la libertà come ricettività, come accoglienza. Da subito Heidegger afferma che la libertà non è una capacità, un possesso dell’uomo, ma al contrario l’uomo ne è posseduto. Nel cristianesimo, da cui Heidegger eredita questo pensiero, vi è, infatti, l’idea che la libertà è ricezione o adesione a qualche cosa di altro da me, cioè non è innanzitutto una mia decisione, ma è riconoscimento dell’essere (questa è la vera libertà e gli animali non hanno questa libertà perché semplicemente reagiscono all’essere, meccanicamente). Ma nel momento in cui Heidegger de-personifica la libertà, non lasciando che si tratti più di una facoltà individuale, ma del neutro Esserci, della neutra decisione gettata, della pura finitezza, ci troviamo in una situazione postcristiana. E allora a questo punto l’“altro” nel cui riconoscimento si deve giocare la libertà non può essere un “altro” che mi raggiunga. Non a caso nella frase che Heidegger cita da Agostino, «Libertas vera est (Christo) servire», il «Christo» deve essere messo tra parentesi. Ed è una aporia che crea dei problemi perché quella frase di Agostino non sarebbe stata possibile mettendo tra parentesi il «Christo». Agostino fa quella scoperta perché c’era quella parola; crea gnoseologicamente dei problemi poter estrapolare quella frase mettendo tra parentesi il motivo della scoperta. 6. La libertà, dunque, non è un possesso dell’uomo ma è piuttosto l’uomo ad essere posseduto da questa libertà. Questa prospettiva è chiaramente presente anche in Essere e Tempo. Tutte quelle visioni della Kehre che vedono in Essere e Tempo un’opera fortemente volontaristica, in cui l’Esserci cioè possiede effettivamente la libertà piuttosto che esserne posseduto, e nella restante produzione heideggeriana la perdita di questa libertà da parte dell’Esserci, dove traggono allora la loro credibilità? Certe letture sono state dettate in gran parte da spunti ideologici; molte di queste sono anche legate ad una certa reazione neoilluminista, ad una certa reazione rispetto alla grande polemica seguita all’affaire del rettorato del 1933, per cui si aveva buon gioco nel dire che il Dasein è l’individuo totalmente depotenziato di una sua capacità decisionale, totalmente schiacciato. Io credo che a distanza di tempo le cose non stiano così, anzi che da un certo punto di vista quelle siano le cose forse più interessanti di Essere e Tempo, cioè il fatto che in qualche modo l’uomo deve fare i conti con la carne viva della sua fatticità, come qualcosa che venga prima di qualsiasi atto di volontà. La tradizione da cui Heidegger prende tutto questo è ovviamente la tradizione del peccato originale; ben prima di qualsiasi auto-determinazione volontaristica c’è la presa d’atto di una insuperabile fragilità. Ma sta di fatto che Heidegger fa rispetto a tutto questo un passo avanti. C’è qui una strana eterogenesi dei fini e a me sembra che si possa rovesciare questa critica: lungi dall’essere un depotenziamento della volontà, forse è una vertiginosa affermazione della volontà, anche se sub contrario. Perché lì dove la finitezza non è più segno o traccia del rapporto con altro da sé, e diventa absoluta, sciolta, allora non come autopotenza ma come impotenza, l’Esserci diventa assolutamente autoreferenziale. |
Cerca tra le risorse
 Giornale Critico di Storia delle Idee
Giornale Critico di Storia delle Idee La filosofia futura
La filosofia futura
Rivista di filosofia teoretica
__________MULTIMEDIA__________
![]() VIDEO
VIDEO
Filippo Mignini
Spinoza: la potenza della ragione
(Emsf)

Gennaro Sasso
Giovanni Gentile: la filosofia, la politica
(Treccani Channel)
Focus
-
 Laicità e filosofia Che cosa significa essere laici nel nostro Paese, dove forte è l'influenza politica della Chiesa? Grandi personalità del pensiero e della cultura riflettono, per la prima volta insieme, su questa questione...vai alla pagina
Laicità e filosofia Che cosa significa essere laici nel nostro Paese, dove forte è l'influenza politica della Chiesa? Grandi personalità del pensiero e della cultura riflettono, per la prima volta insieme, su questa questione...vai alla pagina
- 1
- 2