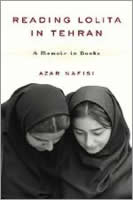Esiste davvero lo scontro di civiltà?
|
|
Micromega/Filosofia.it
Significato della letteratura e senso della realtà, immigrazione e assimilazione, razzismo e religione: due scrittrici di grande successo negli Usa – iraniana trapiantata a Washington la prima, e bengalese-inglese-americana la seconda – discutono di cosa significhi vivere negli Usa, specie dopo l’11 settembre.
(1) Il corpo di Lacey Peterson fu trovato senza vita dopo che la sua scomparsa aveva tenuto col fiato sospeso tutta la nazione. Lacey Peterson era incinta. Ad ucciderla, si scoprì essere stato il marito (n.d.r.).
|
Cerca tra le risorse
 Giornale Critico di Storia delle Idee
Giornale Critico di Storia delle Idee La filosofia futura
La filosofia futura
Rivista di filosofia teoretica
__________MULTIMEDIA__________
![]() VIDEO
VIDEO
Filippo Mignini
Spinoza: la potenza della ragione
(Emsf)

Gennaro Sasso
Giovanni Gentile: la filosofia, la politica
(Treccani Channel)
Focus
-
 Laicità e filosofia Che cosa significa essere laici nel nostro Paese, dove forte è l'influenza politica della Chiesa? Grandi personalità del pensiero e della cultura riflettono, per la prima volta insieme, su questa questione...vai alla pagina
Laicità e filosofia Che cosa significa essere laici nel nostro Paese, dove forte è l'influenza politica della Chiesa? Grandi personalità del pensiero e della cultura riflettono, per la prima volta insieme, su questa questione...vai alla pagina
- 1
- 2